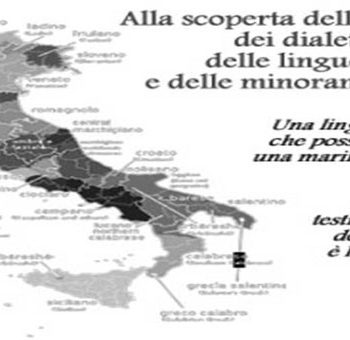Solo tre cose sullo scrivere: poche, ma corpose
di Chiara Lucchini
In un recente intervento al Salone del libro di Torino, Alessandro Baricco ha raccontato le cose che ha capito essere successe negli ultimi venticinque anni nel suo mondo. Uno: il mestiere di scrivere non è più segreto perché gli scrittori parlano (a volte anche troppo). Due: la civiltà dell’immagine profetizzata trent’anni fa non si è avverata, noi oggi scriviamo molto di più. Tre: l’accesso di un maggior numero di persone alla lettura ha cambiato il consumo e l’editoria.
Dovevano essere sette, inizialmente, le cose che Baricco voleva presentare al Salone del libro per spiegare quello che ha capito degli ultimi venticinque anni. Poi si è messo a lavorare e si è accorto che non ne aveva capite sette. Allora ha pensato a sei, ma non ne aveva neanche sei. Cinque è un bel numero, ma non ne aveva neanche cinque. Alla fine ne ha raccolte tre. Tre sono poche. Sono piuttosto corpose, perché smontano, o almeno sfidano, alcune credenze comuni. Però sono poche.
E, per giustificarsi, cita Julien Gracq, scrittore francese molto sofisticato, brillante, polemico, che in un’intervista parlò di una “bolla” in cui si trova lo scrittore. “Una bolla che lui si porta appresso dappertutto, come una stanza in cui vivere, un interno costruito a sua misura”: è lì che è a suo agio. Senza questa bolla protettrice, non si spiegano almeno due cose. La prima è che l’opera di uno scrittore resta sempre coerente, lungo tutta una vita, magari in mezzo a un mondo scatenato. Secondo: senza questa bolla è anche difficile comprendere una certa indifferenza dello scrittore alle vicissitudini della vita letteraria alle quali si trova mescolato.
«C’è questa bolla intorno, e questo spiega perché ho capito solo tre cose. È già tanto che ne abbia capite tre. E vengono più dalla mia esperienza di saggista (I barbari), che non da quella di scrittore di romanzi», dice Baricco.
E poi parte con le tre cose (poche ma corpose) che ha capito.
Gli scrittori parlano
Il primo anno del Salone del libro era molto diverso da come è oggi, era una cosa quasi domestica: molto più piccolo, molte meno persone. C’erano gli scrittori. Le persone non avevano mai visto gli scrittori che leggevano. A un certo punto arrivavi davanti agli stand delle case editrici e li vedevi. Emozione. E ne incontravi anche altri, nei corridoi. Per dirla semplice: gli scrittori non parlavano. Non c’era neanche un dibattito. Forse qualche presentazione. Dovevi avere tu il coraggio di andare a salutarli per dire che eri un loro lettore.
Questa è una cosa che è successa: non c’era, adesso c’è. Questo ha cambiato sia il mestiere di scrivere sia il modo di leggere. Le conseguenze sono in parte buone, ottime. Ad esempio, nel mestiere c’è una componente narcisistica ed esibizionistica fortissima, che ai tempi veniva soffocata nel silenzio. Una volta avevi un premio, o una recensione. Ora per lo scrittore è facile trovarsi davanti a grandi platee. Un mestiere che poteva essere frustrante è diventato un mestiere di grandi soddisfazioni anche fisiche, così ampie che alla lunga si è generato un altro tipo di animale: cioè quello per cui il vero mestiere non è più scrivere, ma andare a parlare di quello che scrivi. Quindi un mestiere che era segreto è diventato pubblico. E questo è positivo, perché gli scrittori hanno liberato qualcosa in loro stessi. Ha risolto il problema del narcisismo, è diventata una situazione più sana.
Una cosa negativa è che gli scrittori dicono un sacco di puttanate. C’è un aspetto grottesco, un mondo dove le parole e le idee sono in saldo totale.
Leggere un libro senza sapere nulla di chi l’aveva scritto era un’esperienza fantastica. C’era l’istinto di conoscere l’autore di cui magari non avevi nemmeno mai visto una fotografia.
La civiltà dell’immagine: una profezia andata nel vuoto
La seconda cosa non è successa. Trent’anni fa c’era una parola d’ordine: una profezia brillante su cui nessuno aveva dubbi. E la profezia era: saremmo diventati presto una civiltà dell’immagine (della civiltà dell’immagine abbiamo parlato anche nell’articolo Cinque mondi). Conseguenza: la scrittura sarebbe avvizzita a poco a poco e diventata uno strumento per pochi scrivani, sostituita completamente da un’umanità diversa che avrebbe comunicato, ragionato, esibito se stessa attraverso l’immagine. In molti ci credevano. È stata una delle intuizioni e delle profezie più brillanti. Ed era una delle profezie più perfette, in cui quadrava tutto. E quello che possiamo dire oggi, dopo trent’anni, è che non è successo.
Un esempio su tutti. Trent’anni fa, nelle case c’erano i telefoni con il filo e i numeri che giravano. E per telefonare alla fidanzata ci si portava il telefono nella stanza, con il filo che veniva fuori. Era evidente che quello strumento andava migliorato, era evidente che non si poteva andare avanti così. Ci si poteva immaginare che si sarebbero pigiati dei tasti per telefonare. Pensando alla civiltà dell’immagine, ci si poteva immaginare di vederla la fidanzata, nel telefono. Ma scrivere nel telefono? A chi è venuto in mente di scrivere nel telefono?
E lì vediamo l’irruzione, la forza della scrittura. Contro ogni profezia intelligente, il mondo voleva la scrittura. E da lì la rete, dove si scrive come non si è mai scritto. E le mail, che neanche nel Settecento quando non avevano niente da fare scrivevano così tanto.
Mail, sms, whatsapp, twitter. Quanto scriviamo.
Dal basso si è costruito un amore per il gesto di scrivere e di leggere massiccio e sterminato.
Allora l’obiezione è: “guarda come scrivono gli sms”. Questa è interpretata come la morte della scrittura: non c’è un congiuntivo. In effetti è così, ma non vuol dir niente. Certo: “Un po’”, non “un pò”: dai, salviamo l’apostrofo. “Non”: perché “nn”? Non moriamo a mettere una “o”. E facciamo un piccolo sforzo a mettere i due punti. E la maiuscola dopo il punto: è bellissima. Punto, spazio, maiuscola. Non buttiamo via queste piccole cose. E prima del “ma”: virgola.
Dov’è che muore la scrittura negli sms? Non in queste piccole cose: lì muore una tradizione, un galateo, che è sempre un peccato, ma pazienza. Il punto è che noi scegliamo di scrivere. Potremmo avere altri sistemi per dire una cosa, e invece la scriviamo. Perché? A volte è timidezza. “Ti ho visto ieri ed eri bellissima”: più facile scriverlo che dirlo. Ma non è solo questo. C’è anche il rapporto tra quello che scriviamo e il tempo per pensarlo, che è all’origine della scrittura. Ci concediamo il tempo. E da quando leggiamo parte qualcosa in noi, che scannerizza le nostre idee e confeziona la risposta. La scrittura ha la chance del tempo e della costruzione.
E anche leggere. È arrivato un messaggio da tuo figlio: lo leggi subito. È arrivato un messaggio da un amico che non vedi da tempo e stai facendo un’altra cosa: aspetti di finire quella cosa.
Quindi pazienza se scappa il “pò” con l’accento. La cosa bella è che noi scegliamo di scrivere quelle sette parole che esprimono il nostro pensiero. Che è una cosa di civiltà grandissima.
Altro che morte della civiltà della scrittura e trionfo della civiltà dell’immagine. Era un mondo che doveva sparire ed è un mondo che è ancora lì.
È difficile che muoia ormai. Non muore nel “pò” con l’accento.
Una cosa in cui muore sono le emoticon, le faccine: sono la sostituzione dell’intelligenza umana alla babbeaggine dell’animale. Le galline usano le emoticon. Proprio perché quello è il tardivo, umiliante, cheap ritorno della civiltà dell’immagine sulla scrittura. I livelli più grevi, più bassi, della civiltà dell’immagine. “Ti odio”, e faccina che ride. Ma perché? Troviamo il modo di dirlo. “Mi sa che ti odio”: io capisco che non è vero.
Quindi è vero che ci sono molte più immagini, ma il dilagare della scrittura è fantastico. Bello. Profezia andata nel vuoto. Le profezie andate nel vuoto ci educano a costruire il futuro, paradossalmente. Queste dimostrano che il futuro è talmente furbo che supera le nostre profezie intelligenti.
La profezia più bella: intorno al 1870, dei serissimi studiosi inglesi fecero un calcolo, considerando l’incremento della popolazione a Londra, l’incremento dei trasporti e dell’economia, e stabilirono che nel 1922 Londra si sarebbe improvvisamente incartata dalla mole indicibile di cacca di cavallo presente in città. La profezia, secondo i calcoli, era perfetta. Poi hanno inventato l’automobile.
Scarpe da tennis per stare sul sofà
Terza cosa. Un po’ complicata, infatti Baricco confessa di averla capita solo fino a un certo punto.
Nel 2006 ha pubblicato Seta. È stato un libro che ha cambiato la sua vita professionale, perché ha fatto di lui uno scrittore planetario e di successo, è rimasto in cima alle classifiche per molto tempo.
Quello che ha capito: vendiamo un numero di libri spaventosamente più alto. Venticinque anni fa vendevamo molti meno libri.
Cos’è successo? Sono diventati più bravi a vendere libri? Anche.
Sostanzialmente, negli ultimi vent’anni un grosso numero di persone che non aveva accesso al mondo dei libri è entrata nel club. Prima non li compravano. Non avevano tempo, soldi e librerie a casa. Da un certo punto è come se si fossero spalancati dei cancelli e ha cominciato a defluire un pubblico che prima non c’era.
Il mondo è cambiato intorno a noi: la gente ha avuto più denaro, più tempo libero, più informazione con la rete. Ed è arrivata un’umanità diversa, che fino agli anni Cinquanta-Sessanta era un club di scacchi: le persone che leggevano erano sempre le stesse. Era un mondo piccolo, un’economia piccola. Procedeva tutto con un passo piccolo e lento.
Quando sono entrati quelli che fino a quel momento erano stati esclusi dal consumo, hanno portato i loro gusti, quello che interessava loro nella vita, le loro tradizioni.
Portarono un’idea di cosa sia il consumo culturale che può essere spiegata così: traiettoria tra punti diversi. Non consumo e approfondimento di un unico punto. Loro hanno portato un istinto che era quello di viaggiare tra punti diversi. E quello era il senso, l’intensità dell’esperienza.
Il consumo loro, e quindi nostro, è di questo tipo. E quindi il mercato è stato segnato da questo tipo di desiderio, di piacere. Questo spiega perché se oggi apriamo una classifica troviamo cuochi, cantanti, calciatori, giornalisti, eroi politici.
Sembra grottesco, e invece è il segno di una civiltà. È un modo di percepire il mondo.
La terza cosa che è successa nel mondo dei libri è questa, e che Baricco definisce “stazione intermedia di sequenze che vengono da tutte le parti”. E va rispettata. Ma resta la domanda: che conseguenza ha avuto questo? Perché quando guardi la classifica hai un senso di frustrazione, perché vedi che un calciatore ha scritto un libro e vende molto di più di gente che scrive e si applica da tutta la vita? Che mondo è un mondo così?
La sensazione che si ha è che tutto vada a rotoli. Se guardi la classifica e vedi che il primo in classifica è l’autobiografia di un calciatore pensi che siamo pazzi. Ma non è così. Dobbiamo avere la freddezza di capire che chi interpreta il libro come in origine era, come un oggetto atto a ospitare bellezza, intensità, lettura e anomalia completamente speciale, deve capire che non è stato abbattuto dalle autobiografie dei calciatori. È lì. Naturalmente è meno visibile. E questo è il difetto del sistema. Non se ne accorge nessuno di un bel libro.
C’è un’idea di libro, che è quella originaria: un sound irripetibile per far accadere uno sguardo che non aveva nessun altro nel mondo, e usando una lingua non come uno strumento, ma creandola, o mettendola in scena. Far accadere queste tre cose in un libro è raro, costa fatica, è legata a pochissimi talenti ed è faticoso da riconoscere nel grande mare di oggi.
Oggi stiamo rischiando di far cadere questo tipo di ambizione e di sogno. Questo sguardo e questa lingua particolare.
Ma questi libri che ti restituiscono la bellezza di una lingua, che ti raccontano una storia, magari con un suono, con un volume, con una luce singolare, si difendono in un solo modo: chi conosce quell’ambizione, chi conosce quella speranza, la porti con sé. Poi suo figlio se ne accorgerà, un altro non se ne accorgerà. Ma se noi la teniamo stretta, nessuno ce la può rubare, nessun sistema commerciale.
E per alzarsi verso quell’ambizione, quel sogno di uno sguardo e di una lingua particolare, Baricco conclude leggendo un racconto di Beppe Fenoglio: Il gorgo. È quello che c’era nell’idea originaria di libro. Nessuno ce lo porterà via.
L’intervento di Baricco al Salone del libro di Torino
- On 12 Settembre 2018