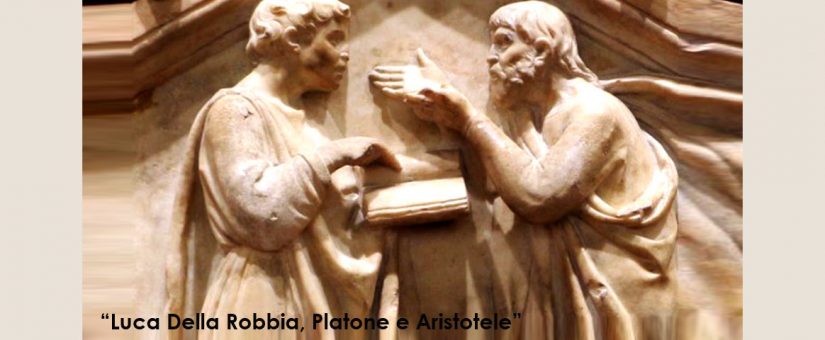
Tesi, antitesi, sintesi.
Formare gli insegnanti per una scuola che adotti il meglio
di Lorenzo Carpanè e Claudia Comaschi
Ricorderemo tutti il 2020 come un anno di crisi. Sta a noi decidere se vogliamo che sia anche un anno di trasformazione. Per tutti, anche per la scuola.
La didattica a distanza sta imponendo nuovi strumenti, ma soprattutto nuovi modelli di insegnamento e di relazione tra docenti, con gli studenti, con le famiglie. Tante rigidità del passato sono superate, si aprono nuovi orizzonti, che sta a noi decidere quali saranno.
Quella che abbiamo davanti è una occasione storica per lasciare ciò che si è dimostrato disfunzionale in questi ultimi decenni e andare oltre, recuperando invece il meglio della tradizione passata.
Si tratta di dare una prospettiva di senso che vada oltre il presente e che rimanga anche dopo.
La scuola italiana è un universo variegato, dove non mancano esperienze innovative di grandissimo spessore, ma nel suo insieme è ancora nella pratica quotidiana largamente focalizzata sui contenuti, meno sulla relazione generativa di contenuti e competenze.
Il punto è esattamente questo: creare le condizioni perché ciascun studente sia sempre più faber ipsae suae fortunae.
In questa situazione contingente, dalla didattica a distanza e dai bisogni che essa genera, cosa possiamo imparare? Come possiamo evolvere? Ecco alcuni temi.
1. Nella vita professionale di domani sarà sempre più frequente utilizzare modalità online per riunioni e per aggiornamento e formazione. Scelta peraltro ecologica: meno spostamenti, meno inquinamento. Le difficoltà che molti insegnanti sottolineano da parte degli studenti di saper intervenire, di intervenire in modo corretto, sia a voce che utilizzando le chat che tutte le piattaforme prevedono, sono temi da considerare: gli studenti vanno educati a saper comunicare anche in queste modalità che saranno parte certa del loro futuro
2. La DAD ha messo in difficoltà docenti e studenti, perché non avvezzi al sistema: nelle difficoltà emergono maggiormente le criticità. Una di queste è la tendenza all’autoreferenzialità. Sopportare un docente che vede gli studenti solo come imbuto per le proprie parole è difficile già in presenza, a distanza ancora di più. Rovesciando la prospettiva, la DAD richiede forme innovative di interazione, legate solo in parte alle tecnologie. Significa che il docente deve acquisire nuove e più avanzate competenze di decodifica dei segnali che arrivano dallo studente anche nelle situazioni mediate
3. Nuova centralità della parola: l’allentamento del valore della materialità dato dalla distanza ci obbliga a un uso più ecologico della parola. Meno parole, più precise, più attente. Quanto è importante ciò nella situazione che già stavamo vivendo prima? Educare gli studenti a questa consapevolezza con gli stessi strumenti che potrebbero essere causa dell’uso improprio (errato, impreciso, inconsapevole) è di grandissimo valore.
4. Comunicazione intermediale: in attesa di tornare ad aggiungere quella in presenza, saper utilizzare i diversi media e le diverse modalità non come somma o alternativa, ma come strumenti tra loro interconnessi, ciascuno con una propria specifica funzione. Anche in questo senso, non solo se ne giova la DAD, ma è anche un’acquisizione utile per gli studenti
5. Rendere più creativi gli studenti cioè più artefici della propria conoscenza. Il tempo è la prima e più importante risorsa umana. Il tempo liberato dagli spostamenti può essere riempito con attività creative, non di solo studio. Per esempio:
a. abolire i manuali scolastici, fare in modo che ciascun studente crei da solo il proprio “manuale”, come del resto avveniva nel passato.
b. Creare, anche in comunità con i colleghi, un proprio archivio di materiali (testi, esercizi, versioni…)
c. Far stendere agli studenti gli appunti su supporto informatico
d. Far loro cercare i materiali disponibili on line, sia testi che critica
e. Far loro costruire esercizi
f. Far diventare l’alunno protagonista della correzione del lavoro del compagno. L’auto apprendimento può passare anche dal lavoro peer to peer
g. Dare compiti che richiedano sempre una capacità critica e creativa e che non siano la sterile ripetizione di ciò che trovano sui manuali o ciò che dice l’insegnante
h. Mettersi (da parte dei docenti) nelle condizioni di essere essi stessi più creativi, anche dopo anni e anni di insegnamento nella stessa disciplina: in questo senso abolire i manuali è un incentivo in un certo senso forzoso
Perché è necessario agire? Perché i trascorsi storici ci insegnano che ad ogni cambiamento dell’assetto relazionale e comunicativo sono seguiti enormi mutamenti sociali, economici, politici.
Guardiamo a cosa è avvenuto con l’introduzione della scrittura: il pensiero da puro spirito si è fatto materia, oggettivabile, trasmissibile.
Con la stampa (vedi MacLuhan), in epoca molto più vicina e noi e ben delimitata di nuovo, è accaduto che
– I tempi della trasmissione del sapere si sono molto ridotti
– La diffusione della cultura è diventata anche un processo produttivo
– Ha permesso a un numero molto più alto di persone di accedere al sapere
– È cambiata la percezione del tempo e dello spazio
Tutto ciò si sta replicando ora:
– Il tempo della trasmissione della cultura si può quasi azzerare
– La diffusione della cultura può essere sottratta al processo produttivo, ma è sottoposta al controllo sociale
– Tutti possono accedere al sapere
– È cambiata nuovamente la percezione del tempo e dello spazio: eterno presente, modernità liquida sono le parole chiave (Bauman).
L’università non sta al momento dando un contributo efficace, presa anch’essa dalle dinamiche della DAD.
Ecco perché ci proponiamo noi con un corso open. Per tutti i dettagli vedi qui
- On 30 Aprile 2020


