Nun ce scassate ’o cazz
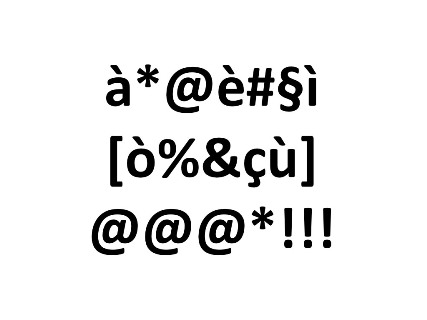 di Alessandro Lucchini
di Alessandro Lucchini
Questo articolo si sarebbe intitolato Elogio della parolaccia, se l’attualità, dio la maledica, non avesse offerto l’occasione di un ricordo affettuoso a Pino Daniele.
Ma non sarà per il puro gusto dell’originalità che, in un luogo di nobili pensieri sulle parole, arriva un elogio alla parolaccia. Che poi, quale originalità, visto che il turpiloquio ha ormai contaminato i giornali, la tivu, il linguaggio comune? E non avrà mica figli questo qui, non dovrà combattere le loro litanie contro i professori crudeli, i compagni bacchettoni, l’allenatore fascista ecc.
Immagino siano state le reazioni più benevole al mio titolo.
Ma la potenza comunicativa della parolaccia e la sua diffusione in ogni ambito sociale, culturale e professionale mi pare meritino qualche considerazione.
Non azzarderò qui un’analisi socio-linguistica della parolaccia, in particolare dei suoi aspetti negativi: dei casi in cui dà realmente fastidio, quando è usata per offendere, quando è sintomo di disagio sociale, di pochezza intellettuale, quando insomma è specchio di ben altri problemi. Mi limiterò a un’osservazione di costume, relativa soprattutto ai casi in cui, completamente desemantizzata, spogliata del ruolo di significato riferito a un vero e proprio significante (pensiamo al tanto di moda “az”), perde ogni carattere di volgarità per assumere un valore di puro divertimento, di formula più simpatica e incisiva per comunicare.
Pensiamo alla politica, per esempio alla rinverdita mitologia del “celodurismo”; pensiamo alla canzone, dallo storico per i ladri e le puttane sono Gesù Bambino di Lucio Dalla, o al catartico Vaffanculo di Masini, o al nun ce scassate ’o cazz di cui sopra.
Pensiamo alla letteratura, che offre esempi anche più nobili. Molto prima delle Storie di ordinaria follia di Bukowsky, ecco il più famoso verso dell’Inferno, censurato da tutti i professori, ma stampato come un’epigrafe nella memoria degli studenti:
ed elli avea del cul fatto trombetta
La citazione dantesca, da cui potremmo risalire per trovare splendidi esempi nella letteratura latina o greca, serve qui a sostenere la tesi: viva la parolaccia, quando aiuta a esprimere un concetto. Senza abuso, senza volgarità, ma anche senza falsi pudori. Il nostro linguaggio è così felicemente ricco di parolacce! Dal punto di vista relazionale, quasi, si potrebbero considerare l’indice della cordialità e della confidenza tra le persone, un po’ come le varie espressioni deittiche. Spesso vengono prima dell’aperitivo, quasi sempre prima del tu.
Le usiamo nel lavoro per impartire un ordine, rafforzare un augurio, scongiurare un pericolo, per commentare la pigrizia del collega, la conferma tanto attesa, la rampogna del capo (rampogna? non è meglio cazziatone?).
Oggi le usiamo abbastanza liberamente anche con i genitori, che abbiamo cominciato a educare intorno ai nostri sedici anni, con i fondamentali (casino, ciula, pirlata ecc.), e che ormai costellano i loro racconti delle assemblee condominiali o delle code al supermercato con energici “quello stronzo, quel rincoglionito, m’han fatto due palle” e via deliziando. Le usiamo con i nostri figli, per avvicinarci a loro, per rallegrare ai loro occhi la nostra immagine, spesso indurita dalla poca frequentazione. Che orgoglio, poi, quando anche loro le usano a proposito!
(Ricordo con tenerezza mia figlia, due anni, su un bagnasciuga: dopo giornate inutilmente spese a familiarizzare col mare, finite sempre in strazianti suppliche di allontanamento, al primo giorno di brutto tempo, quindi senza il tormento degli esercizi con le onde, si piazzò di fronte al mare a gambe larghe, come per urlare più forte, e con inusitata baldanza tuonà: «Mare, vai a tadare!». Oggi è tenerezza; allora fu grande soddisfazione.)
Le parolacce, insomma, fanno parte di quel sotto-linguaggio che ci divertiva molto, da piccoli, ricercare nel vocabolario, ma che oggi ci imbarazza ancora utilizzare nelle occasioni più ufficiali. Non ci vorrà molto, però, perché esse acquistino pubblica dignità e raggiungano – se lo meritano – ogni nobile forma di espressione. Allora lo spregiativo parolacce resterà solo come ruvida e pregnante nota di colore.
P.S. con questo articolo rendo il doveroso omaggio a Vito Tartamella, un giornalista che ho incontrato in un corso, autore del libro Parolacce. Perché le diciamo, che cosa significano, quali effetti hanno, e di un blog sullo stesso tema.
- On 9 Gennaio 2015


