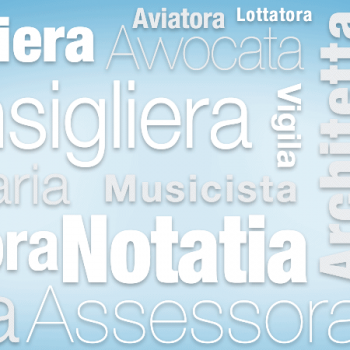Umorismo: da Pirandello alle corsie d’ospedale.
Brescia, 20 aprile 2018: Seminario Comunicazione efficace in sanità: come il linguaggio cambia le percezioni.
Sdrammatizzare, alleggerire. Reincorniciare le situazioni di difficoltà.
di Chiara Lucchini
(Patch Adams)
Ci chiamiamo Palestra della scrittura, e in palestra l’allenamento si fa con la musica. Siamo partiti cantando, chitarra in mano. Gaber, Quello che perde i pezzi. Per aprire una giornata dedicata all’umorismo, ci sembrava adatto. Perde il polpaccio, perde un ginocchio, perde un’ascella, perde un femore, poi dal treno ha perso un braccio salutando (“mi dispiace che c’avevo l’orologio”).
Gaber ci ha aiutato a rompere il ghiaccio. Eravamo in tanti, circa 350, venerdì 20 aprile agli Spedali Civili di Brescia per il seminario “Comunicazione efficace in sanità: come il linguaggio cambia le percezioni. Sdrammatizzare, alleggerire. Reincorniciare le situazioni di difficoltà.” Medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e altri operatori ospedalieri.
L’obiettivo era capire insieme che cos’è l’umorismo, in quali situazioni può essere utile utilizzarlo nel contesto sanitario, e in quale modo.
Che cos’è l’umorismo?
Ma che cos’è l’umorismo? Non facile darne una definizione:
Queste sono parole di Pirandello, che all’umorismo ha dedicato un saggio fondamentale.
Abbiamo chiesto ai partecipanti del corso di dividersi in gruppi e di provare a dare una propria definizione di umorismo. Sono venute fuori queste:
- Capacità di risollevare/rsi l’animo
- Pausa di sollievo emotivo in una situazione di scontro
- Una parentesi rosa tra una rottura di maroni e l’altra
- Sdrammatizzare una situazione e vedere la situazione dall’esterno
- Modificare l’umore sorridendo
- Modo intelligente di sdrammatizzare una situazione
- Atto che scatena una risata
- Capacità di trovare il lato divertente in ogni situazione
- Alleggerire le situazioni usando un linguaggio con forme dialettali e ironiche
Per tornare a Pirandello, nel saggio L’umorismo (1908) l’autore distingue tra comico e umoristico, ricorrendo alla famosissima immagine della vecchia signora.

Il comico, definito come “avvertimento del contrario”, nasce dal contrasto tra l’apparenza e la realtà. Così scriver Pirandello:
«Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di qual orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. “Avverto” che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa espressione comica. Il comico è appunto un “avvertimento del contrario”.»
L’umorismo, il “sentimento del contrario”, invece nasce da una considerazione meno superficiale della situazione, da una riflessione più ponderata, una sorta di compassione da cui si origina un sorriso di comprensione. Se il comico giudica in maniera immediata, l’umorismo è meno spietato e ha il senso di un comune sentimento della fragilità umana. Per tornare all’esempio della vecchia signora:
«Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente, s’inganna che, parata così, nascondendo le rughe e le canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico.»
Umorismo, ironia, sarcasmo
Attenzione a non confondere l’umorismo con l’ironia e il sarcasmo.
Cercando nel vocabolario Treccani, l’umorismo viene definito come “la facoltà, la capacità e il fatto stesso di percepire, esprimere e rappresentare gli aspetti più curiosi, incongruenti e comunque divertenti della realtà che possono suscitare il riso e il sorriso, con umana partecipazione, comprensione e simpatia (e non per solo divertimento e piacere intellettuale o per aspro risentimento morale, che sono i caratteri specifici, rispettivamente, della comicità, dell’arguzia e della satira)”.
L’ironia, invece: “Nell’uso comune, la dissimulazione del proprio pensiero (e la corrispondente figura retorica) con parole che significano il contrario di ciò che si vuol dire, con tono tuttavia che lascia intendere il vero sentimento; In molti casi, il significato della parola si avvicina a quello di beffa, derisione, scherzo crudele o maligno o insultante”.
Infine, il sarcasmo: “Ironia amara e pungente, ispirata da animosità e quindi intesa a offendere e umiliare, che a volte può anche essere espressione di profonda amarezza rivolta, più che contro gli altri, contro sé stessi”.
La violazione della norma
Abbiamo quindi distinto l’umorismo dal sarcasmo: l’umorismo è sempre ridere con qualcuno, mai ridere di. Mai ferire l’altro, mai mettere in ridicolo o in difficoltà il proprio interlocutore.
L’umorismo come violazione della norma, come contrasto tra ciò che accade e le aspettative, cioè una incongruità, una rottura degli schemi, un ribaltamento.
È importante, ovviamente, saper osservare: il momento per fare una battuta va scelto tenendo conto di tutto quanto riguarda il contesto, per comprendere se le altre persone sono capaci di accogliere l’umorismo.
Le qualità del ridere
- La prima qualità del ridere o del sorridere è che fa stare bene. Sono molte le ricerche che dimostrano il valore terapeutico dell’umorismo o il suo positivo impatto sul clima organizzativo.
- La seconda qualità del ridere o del sorridere è che tutti ridono, è un “patrimonio universale dell’umanità”.
- E questo introduce la terza qualità: ridere è contagioso.
- La quarta qualità: ridere è sociale, crea punteggiatura positiva: si ride e ci si diverte insieme.
- Poi: ridere è universale.
- E infine: ridere rende uguali.
Che cosa vi fa partire l’embolo?
Quando ci serve l’umorismo? Soprattutto quando ci sono situazioni che ci fanno irrigidire, e dobbiamo gestire/aggirare delle resistenze.
Abbiamo quindi posto ai partecipanti al corso una domanda: che cosa vi fa partire l’embolo? È venuta fuori una lista di circa trenta frasi che irritano e danno fastidio.
Per esempio: “Sei pagata!”, “Ti pago io lo stipendio!”, “Non siete mai puntuali!”, “Siete sempre in pausa!”, “Vi occupate solo degli extracomunitari!”.

Abbiamo poi provato a immaginare come poter rispondere a queste frasi con risposte di taglio umoristico, applicando il metodo CRG, metodo che viene dalla cultura della negoziazione e che si articola in tre fasi: calibrazione, ricalco e guida.
La calibrazione è lo studio del destinatario, passa attraverso l’osservazione e l’ascolto dell’interlocutore.
Calibrato a fondo l’interlocutore, passiamo alla fase del ricalco: ricalcare qualcuno significa entrare nella sua sfera comunicazionale, vedere le cose dal suo punto di vista, parlare la sua lingua.
Dopo la calibrazione e il ricalco, è il momento di passare alla guida: è questo il momento in cui smettiamo di riprodurre le scelte dell’interlocutore e cominciamo a condurlo verso il nostro obiettivo.
Vediamo qualche esempio di risposte umoristiche:
Sei pagata! |
Preferirei sentirmi appagata! |
Ti pago io lo stipendio. |
Se le risolvo il problema, me lo dà un aumento? |
La sanità fa schifo. |
E non ha visto sotto i sedili della mia macchina! |
Creatività e umorismo
Dote? Talento naturale? O forse anche l’umorismo – come il business writing e il public speaking –
si può allenare? Certo, la creatività aiuta. Scrive Avner Ziv, in Perché no l’umorismo (1981):
- On 22 Aprile 2018